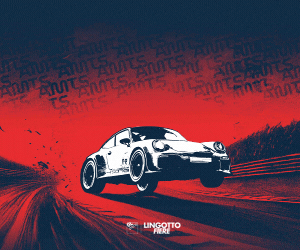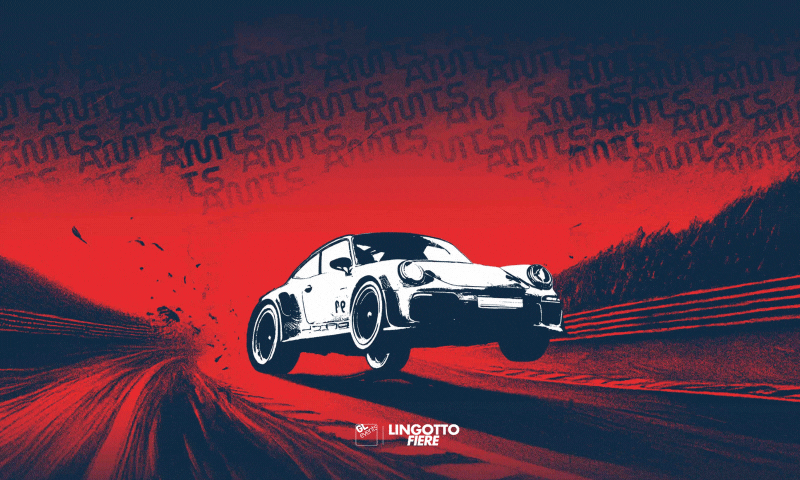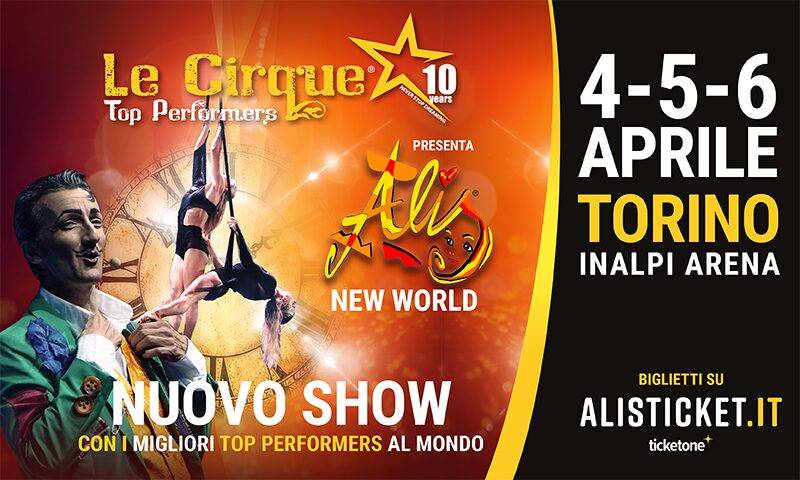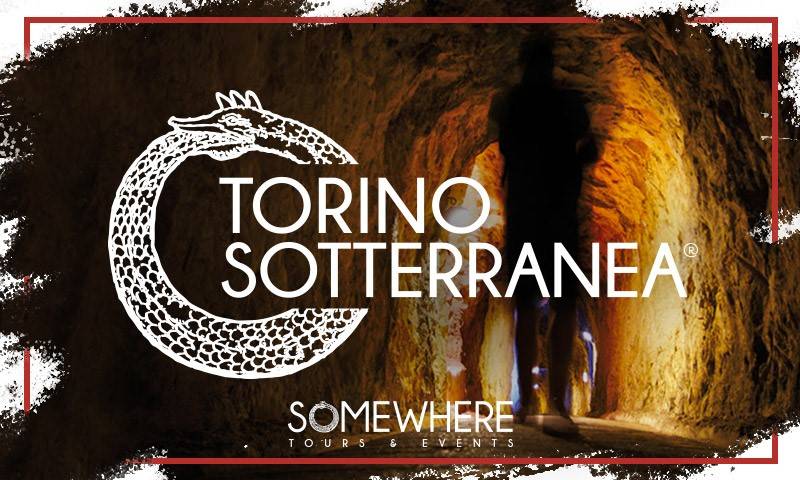La situazione socio politica del tempo era caratterizata da periodi bellici di carattere politico e religioso e da aggiungere vi furono anni dove a causa di avverse condizioni climatiche i raccolti furono molto scarsi. Le condizioni di vita dei cittadini delle campagne era alla fame e molti migrarono in città per cercare fortuna ma di fatto peggiorarono la qualità della vita e un abbassamento notevole delle condizioni igenico-sanitarie. Guerre e fame costrinsero dunque migliaia di persone ad abbandonare le loro case, talvolta le campagne e vedersi costrette alla precaria condizione della mendicanza, muovendo verso i maggiori centri abitati tra cui appunto Torino che, nel 1630, contava oltre 10.000 abitanti.
 Il 2 gennaio 1630 venne segnalato il primo caso di peste a Torino: si trattava di un calzolaio. Non è un caso che sovente le prime vittime erano coloro che lavoravano a diretto contatto con calzature o con oggetti quotidiani in contiguità con il suolo che, troppo spesso, mancava delle più elementari condizioni igieniche. Torino, come le maggiori città piemontesi, vide aumentare la diaspora dalle campagne e dai territori limitrofi, fino a vietare l’ingresso agli stranieri e chiudere le porte della città. L’epidemia si diffuse rapidamente, coinvolgendo anche altri centri della provincia come Pinerolo ed estendendosi poi ai territori del cuneese quali: Alba, Saluzzo e Savigliano. A Torino la situazione raggiunse il culmine della gravità con il sopraggiungere del caldo estivo che favorì la trasmissione del morbo.
Il 2 gennaio 1630 venne segnalato il primo caso di peste a Torino: si trattava di un calzolaio. Non è un caso che sovente le prime vittime erano coloro che lavoravano a diretto contatto con calzature o con oggetti quotidiani in contiguità con il suolo che, troppo spesso, mancava delle più elementari condizioni igieniche. Torino, come le maggiori città piemontesi, vide aumentare la diaspora dalle campagne e dai territori limitrofi, fino a vietare l’ingresso agli stranieri e chiudere le porte della città. L’epidemia si diffuse rapidamente, coinvolgendo anche altri centri della provincia come Pinerolo ed estendendosi poi ai territori del cuneese quali: Alba, Saluzzo e Savigliano. A Torino la situazione raggiunse il culmine della gravità con il sopraggiungere del caldo estivo che favorì la trasmissione del morbo.
Di fondamentale rilevanza furono la figura dell’archiatra e protomedico di Casa Savoia Giovanni Francesco Fiochetto e dell’allora neosindaco Gianfrancesco Bellezia. Il primo è il più famoso tra i vari medici che rimasero in città durante la pestilenza ed è per questo conosciuto come il medico della peste per essere intervenuto, tra il 1630 ed il 1631, intaurando una rigorosa disciplina sanitaria tra la popolazione torinese e che avrebbe fatto scuola negli anni a venire. Il secondo rimase in maniera pressoché continuativa in città, che fu invece abbandonata dalle maggiori figure istituzionali. Gli stessi Savoia si rifugiarono a Cherasco. Eletto Decurione nel 1628 e poi primo sindaco della città proprio nel funesto anno 1630, Bellezia affrontò coraggiosamente il suo mandato diventando il fulcro dell’organizzazione sanitaria attivatasi per affrontare l’emergenza. Inoltre dovette anche contenere l’isteria del popolo nei confronti di episodi di sciacallaggio.
L’epidemia, seppur gestita con coscienzioso scrupolo, fu debellata solo verso novembre del 1630, con il favore del freddo. Su una popolazione di circa 11.000 abitanti, Torino contò la perdita di ben 8.000 persone, una vera ecatombe. Nell’anno seguente e in quello successivo fu registrato un numero enorme di matrimoni. Il 7 aprile dello stesso anno la Pace di Cherasco decretò la fine della guerra per la successione del Ducato di Mantova e si andò quindi ristabilendo un relativo equilibrio; dal mese di settembre i registri di Torino tornarono a riempirsi di nuove nascite. Tuttavia ci vollero quasi due secoli prima di raggiungere nuovamente il numero di abitanti precedente al 1630.
 Vivatorino Notiziario della citta' di Torino
Vivatorino Notiziario della citta' di Torino